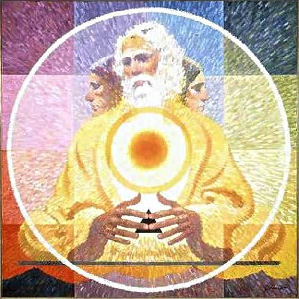Il giovane spinto dalla propria vocazione a iscriversi alla facoltà di medicina non lo fa perché ha una colica e spera con questo atto di eliminarla. I suoi moventi sono più intelligenti e più alti e la sua visione più ampia, anche se, per il momento, solo nel superconscio.
Possiamo dire che chi frequenta medicina per vocazione porta a scuola il futuro medico in lui, e non il piccolo se stesso magari sofferente di coliche e pieno di problemi e istanze propri della sua giovane età.
Se un operaio avverte la necessità di una alta specializzazione cercherà di conseguirla. Mettiamo che si tratti di una specializzazione propria dei dirigenti del suo settore. Quell’operaio, con enorme sacrificio — come di solito accade — andrà là dove la può ottenere, ma non porterà con sé i suoi piccoli problemi di piccolo operaio. A chi gli insegnerà il rapporto energia-lavoro-politica come interazione multinazionale, egli non farà certo domande sul modo di comportarsi col capoturno che non ha simpatia per lui e gli infligge multe ingiuste. È suo interesse conoscere quei problemi nuovi per i quali si sente portato, quelli appunto dei dirigenti in un contesto internazionale o mondiale. Egli ha i suoi problemi personali che possono essere anche gravissimi. Ma ciò che gli interessa è specializzarsi, elevarsi, per risolvere da un livello superiore i problemi di intere categorie. Occupandosi attivamente dei problemi del mondo più ampio nel quale vuole entrare, egli vede in una prospettiva diversa, e perfino dimentica, i suoi problemi personali.
Anche qui vediamo allora che chi frequenta quel corso di alta specializzazione non è l’operaio vessato da un meschino capoturno, ma il futuro dirigente che potrà domani, fra altre cose, essere in grado di migliorare il rapporto capoturno-operaio in generale, in ogni tipo di azienda.
Una semplice donna di casa, provveduto ormai a figli e nipoti, si trova con disponibilità di tempo sufficiente a qualche modesta possibilità. Decide di appagare finalmente un suo profondo interesse, poniamo, per l’archeologia, rimasto sempre inappagato.
La donna, che ha dovuto attendere l’età matura per occuparsi finalmente di ciò che veramente la interessa, non si aspetterà certo che il suo docente la conforti per il dolore della sua vedovanza, o per disamore dei figli, né andrà a piangere sulla sua spalla perché la nuora non la capisce. A lui chiederà la conoscenza nel campo archeologico. Non è una vedova, è madre una suocera piangente che si iscrive all’università, è l’archeologa che fa coraggiosamente quanto occorre per svelarsi in quella donna.
Abbiamo fatto tre esempi non straordinari, diversi fra loro, e pure con un unico denominatore: la sete di conoscenza. E più o meno con una caratteristica comune: il distacco dalla propria condizione contingente per ottenere l’accesso a una condizione superiore.
In nessuno dei tre casi è il piccolo io di oggi che fa, ma è la nuova entità di domani che fa fare, che preme per venire in luce. Non abbiamo uno studentino, un operaio, una donna di casa, ma abbiamo in realtà un medico, un dirigente, un’archeologa, che cominciano a togliere dall’entità compiuta di domani le sovrastrutture che oggi la imprigionano.
Si tratta di individui ancora immersi nel mondo delle forme e dei nomi. Individui che possono essere ancora molto lontani da un risveglio spirituale, che nemmeno conoscono ancora l’esistenza di un Sentiero. E pure da questi esempi possiamo e dobbiamo ricavare un ammaestramento.
Iniziando la nostra vita spirituale dobbiamo individuare quello stesso schema e seguirlo coscientemente. Lo studente, l’operaio, la donna, possono non averne coscienza: a noi non è permesso. Noi dobbiamo conoscere ciò che facciamo, sapere qual è in noi l’Entità di domani che preme per venire in luce, e su quell’Entità tenere fisso lo sguardo senza permettere al piccolo io di oggi di mettervisi davanti. Individuare il campo dell’io e mantenerlo ben distinto dal campo del Sé.
La nota fondamentale che i tre esempi hanno in comune è il profondo, vitale interesse per la nuova attività.
Per quelli di noi in cui questo interesse vitale manca, o non è vitale, o che sono spinti solo da curiosità, da ricerca della sensazione, da nuove dimensioni ove far spaziare l’io, il discorso potrebbe anche fermarsi qui. Non vi può essere progresso là dove non vi è sete di progresso, volontà di progresso, necessità imprescindibile di progresso, sulla base della conoscenza. Quanto all’io, vedremo in seguito come non sia possibile la sua ammissione in questo recinto.
Se l’interesse vitale c’è, allora è possibile cercare di capire le regole alle quali occorre uniformarsi e, avendole capite, impegnarsi ad applicarle. Questo non significa assumere qualcosa nei confronti di qualcuno, ma mettersi al lavoro, e ora vedremo come.
Quando c’è un interesse vitale, una necessità vitale di conoscenza — si tratti di qualunque tipo di yoga o di metafisica realizzativa — non siamo noi, i noi di oggi, a volervisi accostare. Non è l’ingegnere, l’impiegato, il professore, la sarta, non è l’uomo o la donna in noi che vuol apprendere, conoscere, fare; ma è il Realizzato di domani che preme in noi per essere svelato. Svelato, lo sappiamo, significa liberato dai veli, dalle coperture, dalle sovrastrutture che lo ricoprono, e l’Insegnamento ci conduce passo passo in questa effettiva, reale opera di svelamento.
Quindi, chi cerca l’Insegnamento non sono io, piccolo sé pieno di complessi, di incompiutezze, di disarmonia: è il Discepolo in me, che lo cerca. Allora occorre aver ben chiaro questo: alle lezioni, alle conversazioni, all’ashram, ai vari Centri, allo studio comunque avvenga, ci porto soltanto il Discepolo, l’io lo lascio a casa e lo metto fuori della porta, almeno momentaneamente.
Prima di accedere all’Insegnamento, noi non sappiamo chi siamo né dove siamo. Oggi siamo dolore per qualcuno o per qualcosa, domani siamo avversione o dolore per quello stesso oggetto, ieri eravamo solo un grande mal di denti o di qualche altra nostra parte. Siamo, volta a volta, insoddisfazione, allegria, attesa, dolore, dubbio, paura. Ma Io, IO scintilla divina, quale di queste cose sono? Ed è possibile che IO sia soltanto, una volta dopo l’altra, ognuna di queste cose?
Posso arrivare a capire che non è possibile, forse, ma più in là non so andare. Non so tirarmene fuori. Intanto soffro. Sento che IO significa ben altro… ma dove è IO? Come faccio a conoscermi, a trovarmi? E chi è che deve conoscermi, trovarmi? Se sono io, allora devo conoscere e trovare… chi? Che cosa sono, dove sono, chi sono, IO?
Queste domande possono rimanere senza risposta per un tempo più o meno lungo anche per chi si è già accostato allo Yoga, a qualunque tipo di Yoga, se non ha l’atteggiamento giusto. Anzi, la situazione sembra addirittura complicarsi perché domande nuove si aggiungono alle vecchie, sorgono dubbi, si è trascinati in opposte direzioni e presi dall’insoddisfazione.
L’insoddisfazione è inevitabile quando ci accostiamo all’Insegnamento con un errore di prospettiva, cercando solo il piccolo rimedio ai propri mali, o un orecchio compiacente e comprensivo in cui riversare i nostri guai privati, o magari una specie di specchio magico a cui affidare la nostra immagine per vedercela rimandare circonfusa di quell’aureola che siamo convinti di avere… solo che non riusciamo a vederla. Dal punto di vista metafisico realizzativo, la situazione non è diversa quando all’egoismo individuale sostituiamo un egoismo più ampio, alle lamentele personali si sostituiscono quelle per l’ingiustizia sociale, ad esempio, o per la violenza dilagante, cose sulle quali il nostro piccolo io ama pontificare, sdegnarsi, discutere, ascoltandosi, parlare compiaciuto.
Tutto ciò non è da condannare. Tutti siamo o siamo stati così. È solo da sostituire con una nuova prospettiva.
Per quanto dall’Insegnamento siano escluse le nozioni, pure vi sono alcune nozioni che inizialmente è bene apprendere e comprendere. Lo Yoga è Unità e pure occorre incominciare con una divisione — che in seguito è destinata a scomparire. È la divisione fra l’io (l’io empirico, il sentimento dell’io o ahamkara) e il Sé. È una divisione da praticare realmente e rigorosamente, se si vuol vedere la strada su cui si cammina.
I nostri problemi, le nostre sofferenze, i nostri mali, appartengono tutti indistintamente all’io. Il Sé non ha nessun problema, nessuna sofferenza, nessuna malattia.
Non parliamo ovviamente dei nostri vizi. Ma anche le nostre virtù, allo stato energetico attuale, sono tutte dell’io. Il Sé non ha virtù, in questo senso.
La nostra sete di ricerca, di conoscenza, di pace, di compiutezza, e di qualsiasi altro stato, è sempre indistintamente tutta dell’io. Il Sé non ha sete e non ha fame. È compiutezza. È pace. È conoscenza.
Con questo metro — dalla misura che può sembrare forse un po’ abbondante, ma non lo è — è possibile fare una prima indispensabile discriminazione, che a questo punto è ancora semplicemente intellettiva, ma è già tanto che ci si arrivi, anche solo intellettualmente. Possiamo usarla, per intanto, come rimedio di emergenza, una specie di pronto soccorso spirituale. Oppure come una specie di carta stradale, tanto per sapere dove ci troviamo. Se il dubbio ci afferra, se brancoliamo nell’ignoranza e siamo momentaneamente incapaci di comprendere un dato, se l’io ci sopraffà, rapportiamoci per un momento a questa discriminazione integrale, quanto basta per cambiare la nostra prospettiva del momento e permetterci di attendere serenamente, senza essere divorati da debbi, ansie e paure, il momento in cui potremo comprendere dove.
Si può dire che tra il sentimento dell’io (ahamkara) e il Sé c’è un anello di congiunzione: il Discepolo,
Il Discepolo è un tempo, uno stato, un lavoro. Il Discepolo è il Sé ancora velato da tutte le sue coperture.
È il Discepolo in noi che cerca l’Insegnamento.
È l’io distintivo quello che si oppone, e cerca tutte le scuse per ostacolarlo. Quando si dice scuse, si intende ogni genere di cose, l’io è capace di tutto, finche di rendersi malato o di apparire santo, per impedire al Discepolo l’apprendimento.
Le armi più subdole e più frequentemente usate dall’io sono quelle mentali. L’io vuol discutere, ho critica, l’io protesta, l’io è intelligente e non approva ciò che ascolta perché ha un’opinione diversa, l’io sa dì sapere molte cose e si mette in prima fila per farlo sapere agli altri, per ribattere, per contrapporsi.
Questo noi non dobbiamo permettere, e cerchiamo di capire bene perché.
Tra l’io e il Discepolo in noi c’è un gradino mancante — come del resto ce n’è uno tra il Discepolo e il Sé.
Al piano dell’Insegnamento l’io non ha accesso. Vi può accedere soltanto il Discepolo, perché l’Insegnamento è offerto e va compreso in termini di Energie, e non di parole o di formule.
L’io quindi deve rimanere in disparte, non immischiarsi nelle cose dell’Insegnamento. Il Discepolo apprenderà dall’Istruttore, assimilerà l’Insegnamento energeticamente, e provvederà a trasmettere all’io quelle direttive, quei consigli, quella guida che l’io dovrà seguire.
Di solito questo non può avvenire, in principio, con la necessaria efficacia e col giusto ritmo, per quanto volendo si potrebbe fare benissimo. Se, tornato a casa, aggredito dai problemi e dalle istanze e dalle proteste dell’io, ho la capacità e la forza di continuare ad essere il Discepolo, di continuare a far risuonare in me l’Insegnamento avuto, di mantenermi aperto verso l’alto, con calma fiducia, automaticamente i problemi dell’io si risolvono. Pur mancando il gradino, il Discepolo, in queste condizioni, ha il modo di comunicare con l’io.
Se non c’è subito questo giusto atteggiamento, ci sarà un tempo più o meno lungo di interregno, diciamo, una specie dì « terra di nessuno » — in apparenza — in cui non si riesce ancora a far discendere fino all’io, fino alla mente concreta, ciò che il Discepolo ha appreso.
Occorre aver fiducia e stabilire uno stato di vera calma. La difficoltà è solo dell’io, ricordiamolo, e proviene sempre da un nostro errato atteggiamento interiore.
Una grave difficoltà che può sorgere all’inizio, quando non è chiaro il significato di individualità, è lo sgomento che ci assale quando veniamo informati che la dobbiamo uccidere. Possiamo trovarci ad affrontare momenti difficili e penosi: io devo uccidere la mia individualità? Devo uccidere la mia mente? La mia intelligenza, il mio intelletto, il bene più prezioso dell’uomo? Devo forse ridurmi allo stato di deficiente mentale?
Non comprendiamo, perché non siamo andati oltre la lettera delle parole, e d’altra parte sentiamo la nota della verità in quel comandamento, e questo ci fa paura. Siamo spaventati, ma convinti. Avviene cosi che talvolta, dopo tormentose alternative, cadiamo in una passiva rassegnazione e, sentendoci agnelli condotti al sacrificio, dilaniati da sentimenti contrastanti, acconsentiamo —senza nemmeno saper bene a che cosa. Incomincia così un lungo periodo di lotte estenuanti su molti fronti, compreso quello dell’insegnamento a cui — inconsciamente — resistiamo con tutte le nostre forze.
È bene cercare di evitare questo drammatico errore, che deriva solo da mancanza di giusta comprensione. Ricorriamo perciò a una rappresentazione immaginativa della nostra situazione interiore.
L’individualità è stato detto, è la regione, diciamo così, dalla quale Dio si è ritirato per permettere all’uomo-io di esserne il re. In virtù di tale mandato, l’uomo doveva governarsi fino al giorno in cui il vero Governatore avesse ripreso le redini: ed è questo in sostanza che avviene quando ci accostiamo al Sentiero.
Per tutto il tempo in cui il governo gli è rimasto affidato, l’uomo ha fatto in questa regione ciò che ha potuto, e più spesso ciò che ha voluto.
Dentro di lui era rimasto sempre il Governatore, ma inattivo. Solo un filo sottile Lo legava all’uomo, e tramite quel filo l’uomo attingeva da Lui l’energia divina per la sua vita e le sue imprese.
L’uomo è stato grande nei secoli, sia nel bene che nel male. Facendo il male, ha portato quell’energia divina a vibrazioni molto basse e dense, ricoprendo con sempre nuove coperture il Dormente.
Facendo il bene, ha cercato di usare meglio quell’Energia, ma il Sé era già pesantemente velato, e all’uomo è stato facile dimenticarsene del tutto: si è convinto di essere lui la divinità, di essere lui il buono, il giusto, il valoroso, il sapiente. Ha continuato ad attingere a quell’Energia, ma ormai pieno di sé si è convinto di esserne lui la fonte, il creatore, il produttore. Ha nutrito, incensato, ingigantito il proprio io al punto che esso è diventato la copertura maggiore, la sovrapposizione più pesante di Quello.
Sia collettivamente che individualmente, ci siamo creati una individualità artificiale, parassita, basata sull’io che si pone davanti a Quello e, ignorandolo, dice: io ho lavorato, io ho combattuto, io ho scoperto, io ho guarito, io ho creato.
Accostarsi al Sentiero significa accingersi a percorrere a ritroso il cammino fatto nell’errore, togliendo man mano ogni copertura che nel passato abbiamo apposto al Sé – o Atman. Ridimensionando quella individualità parassita e usurpatrice.
Retrocedendo sempre, sempre togliendo sovrastrutture come si tolgono le incrostazioni di terra da un prezioso oggetto di scavo, sempre svelando, fino a riacquistare la nostra dimensione di luce.
L’opera di smantellamento, di eliminazione delle sovrastrutture, va fatta appunto sulla individualità parassita.
Quando pensiamo: io sono buono, io sono giusto, io sono intelligente, io sono generoso, siamo nella individualità.
Quando pensiamo o diciamo: io voglio farmi una posizione, io voglio essere ricco, io voglio essere rispettato, io non voglio sottomettermi, io non accetto consigli, io sono in grado di dare consigli, io voglio questo, io non voglio quello, siamo nell’individualità.
Quando cerchiamo di raggiungere uno scopo, di compiere bei gesti, di ottenere un successo o l’approvazione altrui; quando abbiamo delle reazioni umane di fronte a un’accusa, a una ingiustizia, a un’offesa; quando ci ribelliamo al male, quando desideriamo il bene e la pace, per strano che possa sembrare a prima vista, siamo nella individualità. Non serve continuare perché si può dire, in sintesi, che, qualunque cosa facciamo (o non facciamo), siamo nell’individualità, per il semplice fatto che è compiuta (o non compiuta) dall’io, quindi con un impiego errato di quella Energia al cui libero fluire opponiamo le barriere dell’io.
Naturalmente, non è che dobbiamo rinunciare a tutte queste cose. Anche se per il momento può sembrare un paradosso, occorre dire che anzi dobbiamo proprio pervenire a poterle compiere tutte, se ciò serve al Sé, ma da padroni, non da vittime delle circostanze e degli eventi. Dobbiamo cioè pervenire a quello stato in cui non siamo più vincolati dalle azioni, indifferentemente, nostre né altrui; in cui possiamo agire o non agire, rimanendo in un perfetto equilibrio vibratorio.
Molte volte tutto questo non è compreso, agli inizi. Anche il termine « uccidere » può essere erroneamente interpretato, causando perplessità. Ma esso significa soltanto prendere coscienza della realtà. Mettersi dal punto di vista del Sé. Acquistare la giusta prospettiva, compiendo il necessario lavoro sull’aspetto coscienza.
Abbiamo allora un io empirico, che si è creduto Dio per tanto tempo; e un Sé.
Abbiamo una individualità parassitaria, che significa uso sbagliato delle Energie superiori, e si applica al particolare, e una coscienza universale. Uscendo dall’individualità, non si rimane senza « personalità » come talvolta si teme, sbagliando anche nel termine; ma semplicemente, man mano che usciamo dal particolare, ci trasferiamo nell’universale. Quando l’opera sarà compiuta, non vi sarà più alcuna divisione tra il Sé e il suo strumento.
Abbiamo ancora una mente concreta, analitica (manas) e una mente sintetica, intuitiva (buddhi), alla quale, con la nozione, ci fermeremo perché, quando il Discepolo arriva a questo punto, non ha più bisogno di questo tipo di spiegazioni, in quanto domina ormai il suo campo d’azione, sa per esperienza diretta, conosce.
Nessuno può accostarsi allo yoga o alla metafisica con intento realizzativo se già non è desto in lui il Discepolo.
Tra il Discepolo che si rivela e l’io, generalmente, non c’è comunione, ma c’è contrapposizione, conflitto. Il Discepolo attira e sollecita in una direzione, l’io resiste e trascina nella direzione opposta.
Ognuno di noi deve cercare di conciliare per proprio conto proprio queste due posizioni. Non, beninteso, con compromessi, né con repressioni; ma operando la prima discriminazione effettiva: quello che vuol procedere è il Discepolo in me; questo che si oppone, è l’io.
E poi, intervenendo attivamente con una decisione: quello che voglio seguire, è il Discepolo; quindi l’io devo tenerlo, almeno per il tempo dell’insegnamento o dello studio, fuori da tutto questo.
E subito dopo, stabilendo un programma, il Discepolo avrà l’Insegnamento che gli aspetta, e un po’ alla volta imparerà a educare, guidare, trasformare l’io.
Se solo comprendessimo chiaramente questo atteggiamento, se lo potessimo comprendere e accettare anche razionalmente, come accettiamo il processo implicito in una equazione o in una formula, non ci sarebbe nessun dramma, nessun conflitto, nessuna « uccisione ». Ma solo un progressivo e sereno adattamento dinamico e creativo ai nuovi orizzonti che l’Insegnamento può aprirci uno dopo l’altro, in veloce successione.
Se sappiamo compiere questi primi atti chiarificatori nella nostra coscienza, il Discepolo sarà libero. Non avrà, appeso al collo, l’io che lo intralcia e lo soffoca. Egli dovrà apprendere molte cose, compiere molto lavoro, ma con strumenti ben diversi da quelli fisici dell’io.
Le parole saranno per il Discepolo il primo trabocchetto da superare. Nell’Insegnamento le parole sono soltanto pretesti, supporti per il trasporto di energie. Non hanno più il significato che conosciamo, ma hanno significati di sintesi e contenuto di Energie che dovremo cominciare a conoscere. Parole e frasi ci sembreranno spesso ovvie, o senza senso, o paradossali. Dovremo allora fare molta attenzione, perché ciò significa soltanto che c’è in esse un significato nascosto da comprendere ed effettivi passaggi di coscienza da compiere.
La mente dell’io, la mente distintiva, non ha i mezzi per farlo. Se ci sorprendiamo a tentarlo, ricordiamoci subito che è l’io che si sta intromettendo là dove non deve, e affrettiamoci a rimandarlo al suo posto: così possiamo risparmiarci molto conflitto.
Comprendere quel senso nascosto, effettuare quei passaggi di coscienza, è compito del Discepolo. Dovremo solo attendere con calma fiducia che egli sia completamente desto, attivo, e disponibile.
La mente usata dall’uomo è soltanto quella parte (manas) che è rivolta verso l’io, anche quando si tratta di persone di straordinaria cultura e intelligenza. Buddhi (quella parte della mente rivolta verso il reale, l’assoluto), che dovrà essere per un certo tempo la residenza del Discepolo, è attiva sul suo piano, ma non è in comunicazione con manas. Possiamo considerare che, partendo dal punto massimo di manas, dalla sua vetta più alta, comincia un tratto di sostanza mentale atrofizzata, dopo il quale si apre Buddhi. È questo il secondo gradino mancante nell’organizzazione interiore dell’uomo ai suoi primi passi sul Sentiero.
Il Discepolo dovrà conquistarsi l’obbedienza e anche la collaborazione del suo piccolo io per cominciare a riattivare dal basso quel tratto atrofizzato. È il ponte tra il particolare e l’universale.
Per compiere questo lavoro, è indispensabile il giusto atteggiamento coscienziale. Ciò che ancora non si comprende suscita inevitabilmente delle reazioni, e critiche, interpretazioni analitiche, separativismo, orgoglio, lo impediscono totalmente.
È logico e naturale che vi siano dubbi, incertezze e incomprensione dell’io, poiché l’io non può fare altro che questo. Se noi lasciamo traboccare queste incompiutezze nel tempo dello Insegnamento, automaticamente ne rimaniamo tagliati fuori, e solo per opera nostra,
Occorre riuscire, almeno per quel tempo, a « deporre » il proprio io carico di problemi esattamente come si può deporre un indumento, per poter essere disponibili all’Insegnamento. L’importante è farlo, anche se in principio può sembrare di non esserne capaci. Farlo sempre, abitualmente. Tendere con la coscienza a questo risultato.
E portare con noi l’Insegnamento avuto. Per la strada, a casa, lavorando, studiando, in qualunque situazione, aver presente che ci è stato trasmesso qualche cosa, e attendere. Mantenere un silenzio interno, senza disperdere le energie. Riportarsi interiormente a quella condizione di ricettività. Automaticamente, un po’ alla volta o all’improvviso, non ha importanza, il canale si apre.
Vedremo allora che qualcosa scenderà nella nostra mente. Accogliamone la discesa in consapevole silenzio, e avremo sempre più abbondante l’Insegnamento vero, tanto più abbondante quanto maggiore sarà il silenzio che sapremo ottenere dall’io.